FORMAZIONE
Nell’era digitale il manager diviene un attore chiave dei processi di apprendimento aziendali. Tende così ad affermarsi, secondo una ricerca Fondirigenti, la nuova figura di manager-formatore
Raoul C. D. Nacamulli, Franco Amicucci, Luigi Serio
Ottobre 2024

Le tendenze a livello internazionale e quelle del nostro Paese mostrano l’emergere di una figura di manager diversa da quella del passato: particolarmente orientato allo sviluppo delle competenze di sé stesso e del proprio team di collaboratori, più indirizzato all’empowerment e meno ai rapporti gerarchici, un dirigente più mentore, coach e costruttore di senso piuttosto che un capo tradizionale orientato al controllo e al walking around. Si tratta del manager-formatore, un manager fortemente consapevole che, nell’epoca della quarta rivoluzione industriale e delle piattaforme digitali, il proprio apprendimento e sviluppo e quello dei collaboratori costituisce una sua priorità.
L’emergere della nuova immagine di manager appare collegata, in particolar modo, alla complessità generata dalla trasformazione digitale che, come sottolinea Josh Bersin, mette al centro i processi di apprendimento continuo durante il flusso di lavoro (Bersin J. & Zao-Sanders M., Making Learning Part of Everyday Work, Harvard Business Review, febbraio 2019). L’idea di base è che, nell’era digitale, i processi di apprendimento aziendali risultano essere, in maggior misura che nel passato, parte integrante delle giornate lavorative piuttosto che riferirsi a dei luoghi separati, delle destinazioni. L’apprendimento durante il flusso di lavoro risulta oggi abbondantemente abilitato e facilitato da tecnologie e soluzioni d’avanguardia ma, per potersi realizzare efficacemente, richiede altresì una forte consapevolezza delle persone riguardo alla funzione critica che i processi di apprendimento hanno nel mondo attuale che cambia continuamente.
È in questo scenario che il management diviene, sempre più, un attore strategico per lo sviluppo dei processi di apprendimento individuali e collettivi. In altre parole, con il progredire della digitalizzazione, l’apprendimento appare essere sempre più integrato entro il contesto organizzativo e connesso digitalmente. Ne consegue che i manager, per avere successo, devono essere motivati a puntare sui modelli di leadership e di comportamento organizzativo fortemente orientati al feedback, al miglioramento continuo e alla creazione di un ecosistema in cui si alimenta il processo di valore delle imprese.
È per questo che nasce, si sviluppa e si consolida, non solo nel mondo globale ma anche in Italia, il ruolo di manager-formatore: un manager che ha come proprio punto di forza l’agilità di apprendimento (learning agility) ossia la capacità di cogliere e riflettere continuamente sugli stimoli che derivano dalle nuove sfide ed esperienze per trarne il massimo in termini di sviluppo delle competenze proprie e del suo team. Sullo sviluppo e l’articolazione del ruolo di manager-formatore nel contesto del nostro Paese, Fondirigenti, il Fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti promosso da Confindustria e Federmanager, ha attivato una ricerca la cui struttura e fasi di svolgimento sono riportati nella Tav.1, con l’obiettivo di comprenderne l’articolazione metodologica, le tendenze che sono via via emerse e il set di competenze critiche che caratterizza i manager-formatori nel nostro Paese.
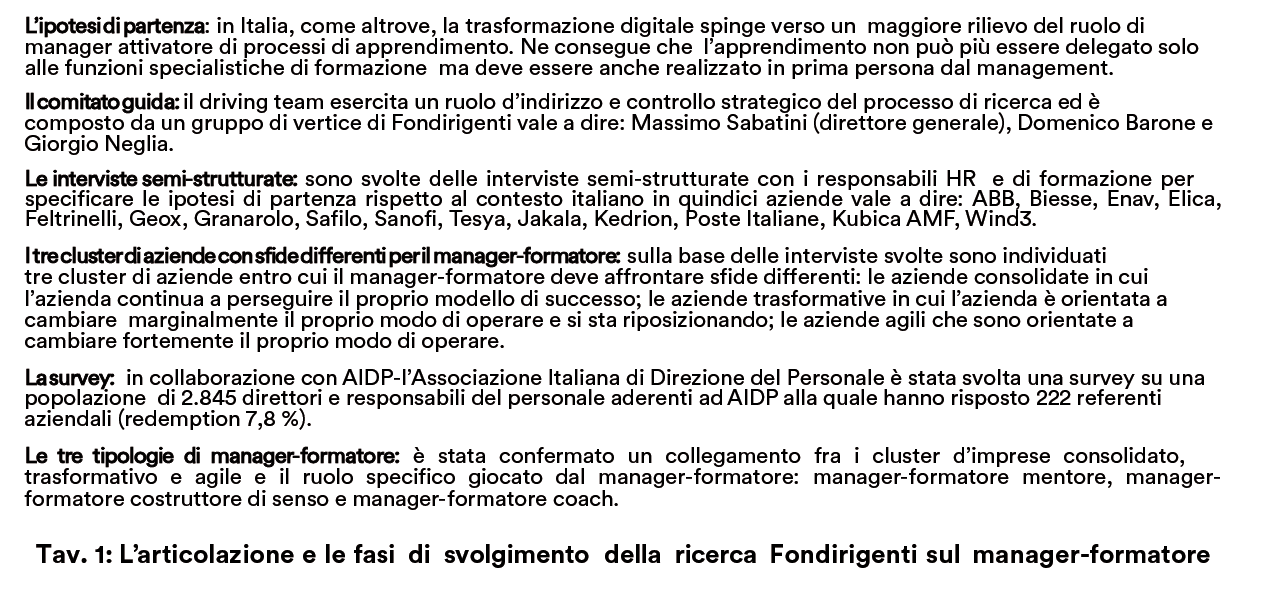
La formazione durante il flusso di lavoro fra trasformazione digitale e governance sociale
Nell’era della rivoluzione digitale, i processi di apprendimento, per essere davvero efficaci, possono svolgersi proficuamente durante il flusso di lavoro in misura maggiore di quanto già avveniva nel passato. L’idea chiave della formazione durante il flusso di lavoro è quella di incoraggiare le opportunità informali di apprendimento trainate dai bisogni dei diretti interessati, facendo sinergia con la formazione formale disegnata e promossa dalle funzioni aziendali dedicate. Questo enfatizzando la visione che nell’era della trasformazione digitale è possibile fare “just in time learning” ossia “apprendere le cose che sono utili quando sono utili”, ottimizzando sia il valore per l’utente che quello per l’azienda.
È in questa maniera che si riesce a fornire ai diretti interessati i contenuti, le capacità e gli strumenti di cui effettivamente sentono il bisogno, in modo efficiente e persistente. Ciò allo scopo di consentire loro di affrontare positivamente le sfide di lavoro che si trovano davanti, in maniera da riuscire a migliorare “just in time” sia la loro soddisfazione che la produttività complessiva.
Come si è detto, l’idea di formazione durante il flusso di lavoro è un concetto sviluppato, diffuso ed enfatizzato attualmente soprattutto da Josh Bersin, che prende atto che oggi e in prospettiva, grazie allo sviluppo digitale, i processi di apprendimento e di formazione si possono svolgere in maniera più allineata alla vita lavorativa di quanto accadeva in passato. Lo sviluppo dei processi di apprendimento e di formazione durante il flusso di lavoro, per avere successo, deve soddisfare due condizioni di base: mettere gli utenti al centro e porre in rilievo che l’interrelazione tra aspetti sociali e tecnici deve essere continuamente ottimizzata. Nella prima prospettiva ci si deve focalizzare sul valore che la formazione ha secondo i fruitori. Ciò seguendo una logica pull, ossia facendo trainare la domanda di apprendimento dai diretti interessati. Nel secondo aspetto si deve puntare su un design dei processi formativi capace di valorizzare sia la componente digitale che quella sociale, attraverso l’identificazione di un ecosistema di occasioni per ottimizzare la fruizione e la condivisione delle opportunità di apprendimento.
Nel complesso si tratta di sostenere e diffondere nei manager, nei collaboratori e nei team di lavoro una cultura evoluta della formazione capace di rafforzare le responsabilità e le capacità di scelta delle persone riguardo ai comportamenti più adatti ad aumentare il ventaglio e la profondità delle competenze. Questo avendo riferimento sia all’apprendimento individuale che ai processi di apprendimento “cooperativo-sociali” basati sulle relazioni e il dialogo.
L’agilità di apprendimento e lo sviluppo manageriale
Un attributo essenziale dei manager orientati in misura maggiore verso l’apprendimento consiste nella loro capacità di attribuire un significato positivo alle proprie esperienze. In altre parole, coloro che hanno una marcia in più nell’era della trasformazione digitale sono quelli che riescono a cogliere rapidamente i vantaggi contenuti in modi di pensare differenti e su questa base riescono a sviluppare ed affinare nuove competenze. Su questa chiave di lettura, l’amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, quasi un decennio fa, in occasione del suo insediamento sottolineava che “per potere avere successo il complesso dei collaboratori di Microsoft doveva riuscire a pensarsi non solo come dei manager e dei team member competenti nelle tecniche gestionali ma anche come degli eterni studenti”. In altre parole, il punto di partenza per il turnaround di Microsoft era, secondo Nadella, far accettare a tutti un nuovo modo di pensare fondato sull’idea che la principale sfida da affrontare nell’era della trasformazione digitale fosse non tanto o solo di tipo tecnologico, quanto di carattere culturale.
Più precisamente, se si voleva avere successo, bisognava puntare, a barra dritta, sullo sviluppo di una cultura del cambiamento: una cultura dell’apprendimento continuo fondata sull’empowerment e sull’intelligenza collettiva; il rafforzamento di una mentalità orientata alla crescita e fondata sulla condivisione delle conoscenze, la riflessione sugli errori, sull’imparare ad “apprendere ad apprendere”, sulla semplificazione delle procedure e sull’agilità organizzativa.
Questo avrebbe comportato il definitivo tramonto della zona di comfort della cultura Knows it All secondo cui tutti sanno già tutto ciò che è necessario per fare bene il proprio lavoro. L’indicazione alternativa è, invece, fare leva sulla cultura Learns it All, che esalta il bisogno di aprirsi al mondo esterno e promuove l’idea di organizzazione che apprende: un’organizzazione che si trasforma continuamente perché è focalizzata sulle capacità di apprendimento continuo dei propri manager e collaboratori.
Questo modo di vedere le cose risulta strettamente collegato al costrutto Growth Mindset: un punto di vista prima coniato e poi perfezionato, nel corso di lunghi studi sul campo, dalla psicologa Carol Dweck della Stanford University, avendo come riferimento le performance di apprendimento degli studenti. Si configura una mentalità di crescita (Growth Mindset) quando le persone sono convinte che le proprie qualità possano essere potenziate e sviluppate grazie all’estrazione di significati positivi dalle esperienze vissute e alla celebrazione del valore dell’apprendimento continuo.
Il Growth Mindset appare essere l’opposto di mentalità statica e consolidata (Fixed Mindset) che fa riferimento a coloro che ritengono che le proprie competenze siano già a regime e quindi non migliorabili in maniera significativa. Satya Nadella applica il concetto Growth Mindset per affrontare e risolvere delle sfide aziendali concrete. Infatti in Microsoft non bisognava soltanto diffondere nuove competenze digitali, ma anche e soprattutto cambiare il modo, rassegnato, in cui le persone avevano fino ad allora affrontato i problemi di declino per rafforzare la loro capacità di reagire alle avversità e allo stress in maniera da raggiungere nuovi traguardi e migliorare continuamente. Questo perché in Microsoft, al tempo, erano diffusi valori e comportamenti autoreferenziali e distruttivi che bisognava riuscire a superare. Difatti, in molti casi, i manager e i loro collaboratori non solo non assegnavano adeguato rilievo allo scenario tecnologico in grande cambiamento, ma anche, invece di lavorare assieme, puntavano sulla competizione e al controllo del proprio raggio di azione consolidato.
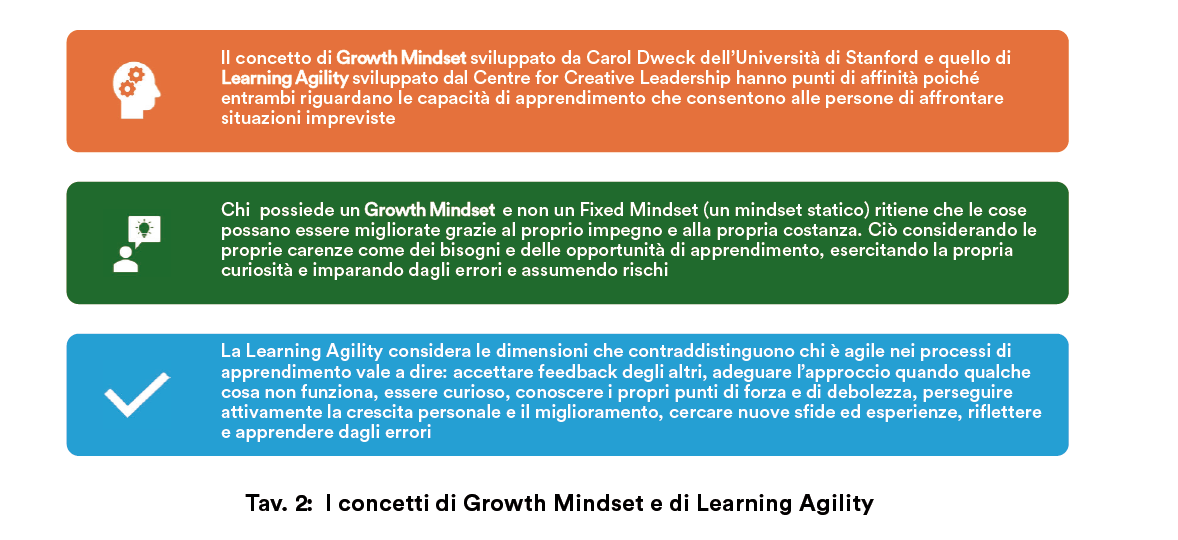
Andando oltre, bisogna sottolineare che il concetto di Growth Mindset risulta strettamente collegato a quello di Agilità di Apprendimento (Learning Agility). Infatti, in un ambiente dinamico, complesso e incerto, la Learning Agility è un fattore molto importante, dato che le competenze manageriali e di leadership sono soggette a una continua obsolescenza, per cui devono essere continuamente rinnovate per far fronte ai mutamenti di contesto.
In questo quadro, le persone, per poter agire in maniera efficace, devono disporre dell’agilità mentale indispensabile per adattare i propri comportamenti al continuo mutare delle situazioni; più specificamente devono disporre di capacità e volontà di apprendere dalle esperienze per poi applicare quanto appreso in condizioni nuove.
Il manager-formatore e le leve agite nei diversi contesti
Nell’era della trasformazione digitale le competenze dei manager e quelle dei leader convergono nelle stesse persone senza soluzione di continuità. In altre parole, le competenze dei manager non sono solo quelle di sviluppare un piano, di stabilire obiettivi di performance, di costruire un budget, d’interpretare i risultati economici e finanziari, di coordinare dei progetti. Nel contesto attuale, i manager debbono essere anche e soprattutto dei leader in grado di guidare e motivare i propri collaboratori verso traguardi generalmente ritenuti non possibili, di sviluppare rapporti di fiducia duraturi nel tempo, di fornire feedback costruttivi orientati allo sviluppo, di sostenere e d’indirizzare con autorevolezza il lavoro contributivo di team orientato al conseguimento di risultati ambiziosi, e di partecipare allo sviluppo delle competenze e delle abilità necessarie a svolgere il lavoro quotidiano. Ma soprattutto, il manager-formatore deve riuscire a superare la visione che l’urgenza del lavoro debba avere la meglio sul lusso dell’apprendimento.
D’altra parte, i processi di apprendimento individuali e sociali sono influenzati da diversi fattori, fra cui in particolare il contesto in cui si sta apprendendo, l’intensità della motivazione ad apprendere, la selezione delle fonti di apprendimento e le dinamiche e il governo dei processi d’interazione con gli altri durante i processi di apprendimento. L’attività di facilitazione dell’apprendimento svolta dai manager avviene attraverso il feedback riguardo alle esperienze vissute dai collaboratori per lo sviluppo delle competenze. Questo con riferimento a comportamenti quali: porre domande, scambiare soluzioni, esplorare nuove idee, indicare percorsi di crescita. Perciò il manager-formatore si caratterizza per l’orientamento a continuare ad imparare e per la propria predisposizione al sostegno di una cultura dei propri collaboratori fortemente orientata verso l’apprendimento continuo.
Dunque, entro ciascuna organizzazione risulta importante stabilire quale deve essere l’equilibrio a tendere fra i bisogni di apprendimento adattativo ed evolutivo e quindi come deve modularsi il ruolo dei manager formatori fra il mentoring, il coaching ed il counseling.
Una bussola per definire il ruolo manager-formatore nelle aziende italiane
Il manager-formatore è più orientato all’empowerment e allo sviluppo delle competenze proprie e di quelle dei team di collaboratori, e per questa ragione è più un allenatore e una guida che un capo gerarchico. L’affermazione della figura del manager-formatore è spinta dai cambiamenti culturali e organizzativi indotti dalla trasformazione digitale. Il ruolo del manager-formatore è emergente innanzitutto nelle aziende high-tech, nelle quali sono particolarmente evidenti i fabbisogni di apprendimento continuo durante il flusso di lavoro. Il ruolo del manager-formatore si è poi progressivamente diffuso sia nel manifatturiero avanzato che nel complesso degli altri settori economici dove viene sempre più apprezzato. Questo anche perché sia a livello globale che nel complesso delle aziende del nostro Paese, grazie alla digitalizzazione e al fabbisogno di competenze digitali evolute, si sono fatti strada modelli di lavoro sempre più orizzontali e agili. Certo, i modelli organizzativi gerarchici continuano a permanere ma aumenta il volume di attività su progetto e l’estensione del lavoro interfunzionale svolto in team. Insomma, i processi di trasformazione digitale e di cambiamento continuo delineano, anche in Italia, lo sviluppo e la diffusione di un ruolo nuovo di manager per cui risulta centrale il presidio dei processi di apprendimento. In questo quadro è verosimile pensare che il ruolo di manager-formatore si declini diversamente nelle imprese a seconda del contesto e delle sfide a cui debbono fare fronte. Questo perché, come è stato sottolineato precedentemente, le modalità con cui i processi di apprendimento individuali, sociali ed organizzativi avvengono risultano influenzati, in particolar modo, dalla strutturazione del contesto a cui si riferiscono. Diviene quindi più che mai utile disporre di una bussola che possa indirizzare i manager – formatori nel disegno e nello sviluppo del proprio ruolo nel panorama delle aziende del nostro Paese.
Questo lo scenario in cui si inserisce la ricerca promossa da Fondirigenti nelle imprese italiane sul ruolo del management nell’apprendere ad apprendere https://www.fondirigenti.it/web/OIL. Sullo sfondo emergono due traiettorie complementari di sviluppo da indagare: la differente strutturazione dei contesti aziendali di riferimento che i manager-formatori si trovano di fronte e l’evoluzione del ruolo manageriale e quella del suo set di competenze critico. L’ipotesi di partenza dell’indagine sottolinea come, anche nel nostro Paese, il management rappresenta, sempre più, un attore strategico nello sviluppo dei processi di apprendimento individuale e collettivo. Ciò entro uno scenario in cui l’apprendimento appare sempre più connesso ed integrato all’evoluzione del contesto organizzativo. Un’ulteriore ipotesi sottolinea poi che il ruolo del manager-formatore si configura e si declina diversamente entro categorie d’imprese differenziate in particolar modo avendo riguardo ai contesti adattivi ed evolutivi così come precisato nel precedente paragrafo. Infatti, in special modo nel nostro Paese, sono rappresentate diverse categorie di aziende che debbono affrontare sfide legate ad ambienti differenti. Questo non solo perché appartengono a cluster più o meno avanzati sul piano della trasformazione digitale ma anche perché vivono contesti istituzionali, territoriali e di mercato diversi.
La prima fase della ricerca ha avuto come obiettivo quello di fornire una risposta alla domanda: “Come è possibile distinguere in categorie le imprese italiane per precisare il ruolo del dirigente-formatore in ciascuna di esse?” Per fare questo è stata individuata una short list di quindici aziende che pur operando in contesti diversi e vivendo sfide eterogenee avevano già definito e fatto evolvere il ruolo di manager- formatore. Ciò avendo già disposto, in maniera implicita od esplicita, delle pratiche utili a questo riguardo. I risultati emersi dalle interviste svolte in ciascuna di queste imprese hanno consentito di specificare tre gruppi di aziende di riferimento. Nel “modello consolidato” l’azienda non ha cambiato sensibilmente il proprio modo di operare e continua a perseguire il proprio modello di successo. Nel “modello trasformativo” l’azienda ha cambiato marginalmente il proprio modo di operare (ad es. ha cominciato ad operare in nuovi segmenti di mercato, ha sviluppato prodotti e tecnologie nuove, ha introdotto nuovi profili di personale). Nel “modello agile” l’azienda ha fortemente cambiato il proprio modo di operare, sono avvenute delle modifiche nel sistema di governance e ha dovuto ristrutturarsi a livello organizzativo e di mix quantitativo e qualitativo delle risorse umane.
Secondo questo quadro di riferimento è stata svolta una survey su una popolazione di 2845 direttori e responsabili del personale aderenti ad AIDP, l’associazione italiana di direzione del personale che ha avuto una redemption del 7,8%, avendo risposto 222 referenti aziendali. Dal complesso delle analisi svolte emerge come in corrispondenza delle imprese consolidate, trasformative e agili prevalgono tre differenti tipologie di manager-formatore: il mentore, il costruttore di senso e il coach.
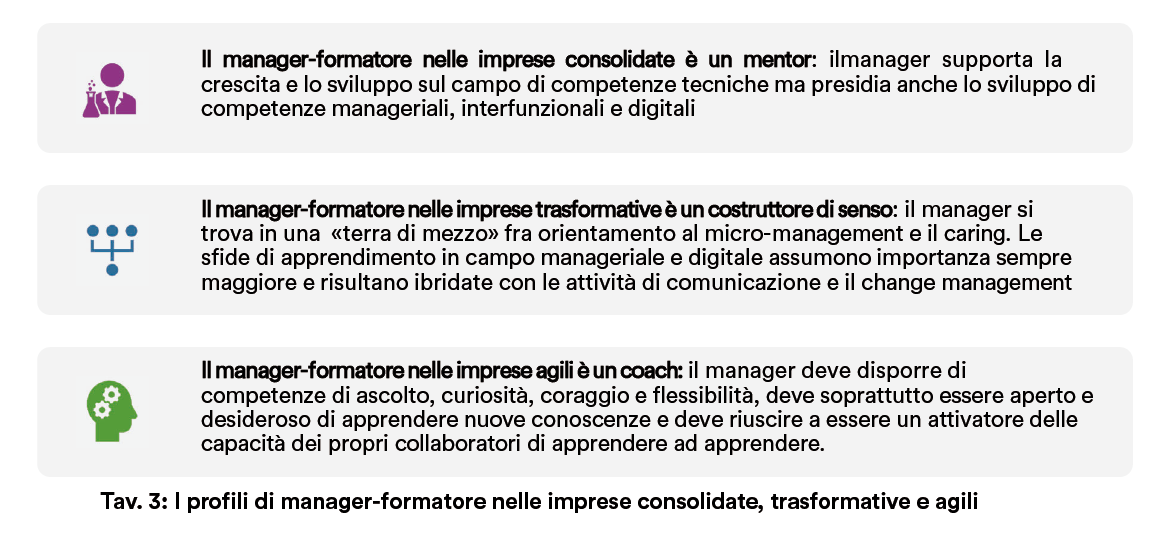
Il mentore che prevale nelle imprese consolidate è più focalizzato sullo sviluppo delle competenze tecniche durante il flusso di lavoro. Questo mentre opera in partnership con la funzione HR riguardo allo sviluppo delle competenze manageriali e con la funzione IT per lo sviluppo delle competenze digitali di base (digital literacy). Il costruttore di senso che predomina delle imprese trasformative opera direttamente durante il flusso di lavoro per generare consapevolezza e sviluppare sia le competenze di gestione che quelle di sviluppo dei team. Questo mentre lavora in partnership con le funzioni di comunicazione aziendale riguardo alle competenze di orientamento strategico e di digital social learning e poi insieme alla funzione HR riguardo alle competenze di change management. Infine il coach che è caratteristico delle imprese agili è particolarmente attento all’allenamento diretto durante il flusso di lavoro riguardo alle competenze di learning agility (apprendere ad apprendere, curiosità ed empatia) e a quelle di project management; presidia poi, in partnership con le funzioni HR e comunicazione, lo sviluppo di competenze digitali evolute. Inoltre, i risultati dell’indagine svolta mettono in rilievo come a seguito della pandemia e per effetto della trasformazione digitale si avverte il fabbisogno che i manager dispongano di una maggiore familiarità con le competenze digitali e sentano l’esigenza di promuovere un più elevato orientamento alla delega ed al feedback dei loro collaboratori. In particolare, i manager ad alta performance sono quelli giudicati capaci di affrontare sfide difficili facendo leva su un mindset orientato alla learning agility per apprendere dalle esperienze, e sono coloro che desiderano formarsi sia apprendendo sul campo entro i team di lavoro che attraverso il feedback dei colleghi e dei capi, che partecipando a corsi di formazione in aule fisiche e virtuali ed a progetti innovativi. Inoltre, i manager-formatori desiderano, da un lato, disporre di competenze che li pongano in grado di comprendere il proprio contesto strategico e organizzativo e dall’altro migliorare la propria occupabilità in azienda e nel mercato del lavoro e che sono motivati ad intervenire sui processi formativi dei propri collaboratori, stimolandoli ed orientandoli nei loro percorsi di apprendimento.
Come riuscire a diventare un manager-formatore di successo
Appare chiaro come nell’era della trasformazione digitale il management deve giocare sempre più un ruolo di attore strategico per lo sviluppo dei processi di apprendimento individuale e collettivo. Questo perché il processo di apprendimento di nuove competenze (re-skilling) e la capacità di sviluppare e riqualificare le competenze (up-skilling) sono divenute essenziali. Infatti, non è certo un caso che la competenza “apprendere ad apprendere” rientri tra le raccomandazioni del Consiglio e del Parlamento Europeo, a partire da Lisbona 2000, ed è considerata una delle competenze chiave del XXI secolo da organismi internazionali, come OCSE, UNESCO, World Economic Forum. Insomma, oggi e in prospettiva, l’apprendimento non può più essere delegato solo alle funzioni specialistiche di formazione, ma deve essere anche e soprattutto realizzato, in prima persona, dal management attraverso la valorizzazione di modelli orientati al feedback, al miglioramento continuo e all’innovazione durante il flusso di lavoro.
Più in particolare il manager-formatore per avere successo deve disporre di due competenze chiave: capire lo scenario di business ed essere in grado di costruire un contesto di apprendimento stimolante e ricco di occasioni formative. La prima competenza chiave risulta fondamentale per consentire al dirigente di guidare ed orientare consapevolmente il proprio team di lavoro nelle transizioni orientate allo sviluppo. Non si tratta tanto e solo di conoscere i trend aziendali ma risulta necessario soprattutto saper inquadrare i fenomeni in maniera da riuscire a trasferirli efficacemente al proprio team nell’azione quotidiana. La seconda competenza riguarda specificamente il ruolo del manager-formatore che deve essere inteso come «architetto» e «facilitatore» di un contesto favorevole all’apprendimento. Ciò attraverso i processi di orientamento e di stimolo dei processi di apprendimento di sé stesso e dei propri collaboratori, e cogliendo in maniera accorta l’ampia gamma di opportunità di apprendimento presenti nel flusso di lavoro. Un contesto che da una parte “attrae e trattiene” le persone in azienda e dall’altra crea il nuovo campo in cui si gioca la competizione e l’alimentazione dei processi di creazione di valore nel prossimo futuro.
Raoul C. D. Nacamulli è professore di Organizzazione Aziendale ed è fondatore di OpenOrg, Franco Amicucci è Presidente di Skilla ed è tra i pionieri del Digital Learning in Italia, Luigi Serio è docente di Economia e Gestione delle Imprese all’Università Cattolica e insegna all’ISTUD.