RISORSE UMANE
Marco Valerio Morelli, Amelia Venegoni
Marzo 2023

Nel giugno del 2020, tre mesi dopo l'arrivo della pandemia, il mondo ha assistito a una rapida accelerazione verso la digitalizzazione in soli 90 giorni. Questo fenomeno ha generato conseguenze non solo sulle tecnologie abilitanti che utilizziamo per collaborare in remoto, come Zoom, Teams e Office, ma anche sul tasso di automazione delle attività lavorative e sul processo di trasformazione dei processi aziendali. I cambiamenti avvenuti negli ultimi due anni hanno pertanto avuto effetti molto più profondi di quanto possiamo immaginare: è come se una tendenza ventennale fosse stata accelerata in soli 24 mesi.
Per dare un'idea del cambiamento che abbiamo avuto, solo per prendere in considerazione un Paese, negli Stati Uniti negli anni ’50 solo il 6% dei dipendenti lavorava a tempo pieno da remoto, contro circa il 56% di oggi. Oltre alla transizione tecnologica, questo cambiamento ha mutato anche il modo in cui i lavoratori esprimono una valutazione rispetto alla propria azienda. Le persone hanno cominciato ad andare oltre dove, come e quando lavorare, e ora esplorano anche il perché, lo scopo della propria mansione e il ruolo identitario nell’ambito dell’organizzazione. Inoltre si chiedono se i propri obiettivi personali siano allineati alla missione e al purpose dell’organizzazione in cui sono inseriti, per avere la conferma di poter lasciare un segno che generi un effetto positivo sulla società.
In generale, la pandemia ha segnato un passaggio fondamentale da una tradizionale attenzione alla crescita e all'efficienza a un'enfasi sempre maggiore sulla flessibilità, sulla resilienza e sull'agilità che garantiscano nel contempo la sostenibilità economica. Spesso parliamo del Covid come se fosse una rara catastrofe, ma in realtà abbiamo avuto almeno altri quattro eventi catastrofici negli ultimi 20 anni: l’11 settembre, la crisi finanziaria del 2008, la pandemia e ora un’altra guerra in Europa. Non dobbiamo pensare al Covid come al “Cigno nero” della nostra epoca, ma come un evento dirompente che caratterizza questa nuova normalità. La domanda a questo punto è come costruire aziende in grado di resistere a questi shock e trasformarli in un’occasione di crescita.
La risposta risiede in due elementi importanti: innanzitutto avere business leader con la capacità, gli strumenti e le intuizioni per orchestrare il lavoro in modi fondamentalmente diversi, prendendo decisioni con responsabilità; e in secondo luogo soddisfare la promessa di agilità per consentire ai giovani talenti di connettersi “senza soluzione di continuità” al proprio lavoro.
Partendo dal primo elemento, quello dei business leader, possiamo osservare come le aziende guidate da CEO illuminati si stiano orientando decisamente verso un ridisegno del lavoro che consenta alle persone di agire in modo flessibile, produttivo ed efficace. Un modello di questo tipo non solo trattiene i lavoratori più importanti per il buon andamento dell’organizzazione, ma aiuta ad attrarre le competenze che servono e a promuovere una cultura inclusiva e sostenibile. La cura delle risorse e il nutrimento rispetto alle motivazioni che li guidano vanno però inseriti in un modello operativo che consenta all’azienda di reinventarsi, senza perdere focalizzazione e adesione a una missione e un purpose distintivi. È obsoleto pensare di utilizzare una soluzione unica solo perché ha funzionato negli ultimi 20 anni: oggi le pressioni inflazionistiche e recessive impongono di cambiare e di rinnovarsi costantemente. Il business leader deve, dunque, continuare a chiedersi quale sia il miglior modo per creare un legame forte tra i giovani e il proprio lavoro e come rendere ottimale la relazione dipendente-organizzazione, senza fermarsi alla prima soluzione che sembra funzionare.
Vincere la sfida della flessibilità
Il modello flessibile dell’organizzazione è principalmente quello in cui alle persone viene offerta la possibilità di esprimere le proprie competenze in ambiti diversi. Se un dipendente ha competenze analitiche nella finanza e nel controllo di gestione, per esempio, può collaborare con le risorse umane in un progetto sulla performance nei sistemi di incentivazione o su tematiche di sostenibilità, contribuendo con le sue conoscenze e imparando a strutturarle in ambiti differenti. Il modello flessibile è una delle prime applicazioni che consente una mobilità interna non solo limitata ai posti di lavoro, ma anche agli incarichi, ai progetti e ai compiti.
In questo senso, la pianificazione della forza lavoro diventa molto interessante, in quanto non si tratta di spostare le persone da una posizione all'altra, ma di pianificare e allocare le competenze e le capacità disponibili che meglio possono aiutare l’organizzazione nel raggiungimento di un obiettivo. Quello che si deve considerare è chi ha le competenze migliori per svolgere un determinato lavoro e come potrebbe contribuire utilizzando le proprie conoscenze in modo trasversale, al di là del proprio ruolo formale.
Abbiamo superato il modello della retribuzione basata sul ruolo: oggi le aziende e i manager utilizzano un sistema retributivo basato su obiettivi e competenze. Abbiamo infatti gli strumenti e la tecnologia per valutare il mercato e le diverse skill che esso richiede per poi commercializzarle alle aziende. Si tratta di algoritmi che, esaminando il numero di progetti in corso, analizzano le competenze richieste e la relativa importanza, identificano il profilo idoneo e il premio più adeguato: la struttura retributiva alla base è chiaramente diversa: una volta inserita, la retribuzione di base viene modificata a seconda delle conoscenze possedute dal singolo. In questo modo i benefici sono indicizzati al salario di partenza e si ottiene un premio finale basato sul valore che le diverse organizzazioni attribuiscono a determinate competenze nei diversi progetti di lavoro. Oltre poi ad aggiungere la componente variabile basata poi sugli obiettivi effettivamente raggiunti applicando le proprie competenze.
Comprendere quali siano le competenze più importanti e come valutarle è al centro di quello che stiamo vivendo e che continueremo a vivere nel futuro mondo del lavoro. Gli analfabeti del ventunesimo secolo non saranno più coloro che non sono in grado di leggere e scrivere, ma chi non sarà disposto a imparare, disimparare e reimparare nuovi modi di lavorare.
Un esempio di skill based organization è quello di Brembo che, nell’ambito di un programma di long life learning avviato nel 2017, ha lanciato Skill Factory, strumento per scardinare la tradizionale visione che ha sempre portato a lavorare su set di competenze tradizionali. Insieme, HR e linee di business hanno condotto una co-progettazione degli strumenti per valutare librerie di skill. Con questo progetto le Risorse Umane non si sono dunque limitate ad assumere solo un ruolo di facilitatore delle competenze delle persone, ma sono entrate nel dettaglio per comprendere i problemi di business, rendendo sempre più rilevante il lavoro di collaborazione con il business stesso.
Si è trattato di una vera e propria trasformazione culturale e digitale per standardizzare e globalizzare i processi, oltre a iniziare a ragionare sul set di competenze digitali che caratterizzano determinate famiglie professionali. Il concetto di “fabbrica” (factory) ha poi aiutato a definire tavoli permanenti costituiti dagli esperti HR e da partner esterni che hanno consentito di avere uno sguardo allargato nella definizione delle competenze, anche cogliendo alcuni elementi abilitanti per definire librerie continuamente aggiornate e con un dettaglio inedito. E alla base di tutto ciò c’è stata una corposa cultura dell’HR Analytics anche a livello delle singole geografie.
Animali sociali. Retribuiti
Considerata la rifocalizzazione delle aziende più innovative sul tema della flessibilità e della competenza, occorre però fermarsi a riflettere su come, con l’emergenza pandemica, è aumentato notevolmente, da parte di tutte le generazioni, il bisogno di socialità. Da un lato emerge il bisogno di flessibilità, un grande desiderio di poter lavorare da dove si desidera, mettendo a frutto le competenze che l’azienda sta imparando a riconoscere; ma dall’altro lato il lavoratore chiede di avere la scelta di poter continuare a vivere una connessione sociale, scegliere di poter tornare in ufficio per interagire con diverse tipologie di colleghi.
Dunque, il Covid-19 ha generato due bisogni sui quali i lavoratori si sono focalizzati: il desiderio di flessibilità e la ricerca della salute, fisica e mentale. In questo contesto le aziende devono investire ancora di più su un modello retributivo di total reward che includa strumenti di protezione della salute, oltre a politiche che favoriscano la flessibilità dell’orario lavorativo e, nel contempo, promuovano l’utilizzo di strumenti di collaborazione e connessione tra le persone. Per esempio, riconoscendo fringe benefit per attutire l’impatto relativo all’aumento del costo della vita, avviando supporti e sostegni preventivi in materia di benessere fisico e mentale, predisponendo una copertura assistenziale e sanitaria ampia, che garantisca il benessere del dipendente e della propria famiglia.
L’azienda empatica
E non è più un fatto di cash anche il mantenimento da parte dei lavoratori di alti livelli di ingaggio e senso di appartenenza. In questo contesto diventa fondamentale intercettare le diverse motivazioni che caratterizzano i rappresentanti delle diverse generazioni, evitando l’errore di proposte univoche percepite distanti da sé e con impatti finali scarsamente rilevanti. In questo contesto esiste una fondamentale sfida da affrontare oggi, in particolare nel nostro Paese: la multigenerazionalità in azienda.
È utile inquadrare queste riflessioni in una lettura evolutiva di come si è modificato nel tempo il contratto psicologico tra l’azienda e il dipendente, rileggendo questi cambiamenti anche alla luce delle peculiarità portate dalle diverse generazioni che negli anni sono entrate nel mondo del lavoro. Come sottolineato anche dallo studio Mercer Global Talent Trend 2022, infatti, il patto azienda-dipendente si è trasformato nel corso degli ultimi decenni.
Il “patto di fidelizzazione” che ha caratterizzato i Baby Boomer, cresciuti con la prospettiva di una long-life career, era basato in primo luogo sul soddisfacimento dei propri bisogni di base. Oggi la prospettiva di un’intera vita professionale spesa all’interna di una stessa azienda ha lasciato spazio, con l’arrivo degli esponenti della generazione X, alla centralità di nuovi bisogni e aspettative: carriera, realizzazione del sé e sicurezza. I Millennial – che ad oggi costituiscono all’incirca il 40% della forza lavoro – hanno spinto le aziende a proporre un contratto basato sul “thrive”, dove al centro viene messo lo sviluppo della persona nella sua interezza: la ricerca di senso e le opportunità di crescita del proprio potenziale sono per i Millennial elementi di ingaggio determinanti.
La Generazione Z, infine, che si affaccia oggi al mondo del lavoro (i GenZ costituiscono ad oggi oltre il 10% della popolazione occupata), sfida le aziende a trovare forme e modi di valorizzazione delle persone a partire dalle peculiarità che ciascuno di loro può esprimere: il nuovo contratto risorsa-azienda si basa ora sulla possibilità di affrontare esperienze diversificate all’interno dell’organizzazione per il tempo limitato in cui la si abiterà, sullo sviluppare connessioni e sul poter portare il proprio peculiare contributo, in un contesto di crescente mobilità e flessibilità.
Serve dunque un modello di gestione più evoluto, che analizzi, interiorizzi e comprenda la compresenza di quattro generazioni con modelli di ingaggio ed elementi di motivazione differenti. E, per ottenere questo modello organizzativo, si deve partire da una maggiore capacità di ascolto e dalla pianificazione di strumenti di raccolta e analisi delle istanze che emergono dalla forza lavoro. L’ascolto va poi differenziato in base alla generazione alla quale ci si rivolge e quindi messo in pratica, esprimendo un modello di leadership empatica e inclusiva, la sola in grado di trasferire correttamente modelli di gestione necessariamente diversificati.
Gli impatti sulla leadership
L’evoluzione delle esigenze espresse dalle diverse generazioni impatta fortemente il ruolo della leadership, chiamata sempre di più ad essere human-centric, capace di sintonizzarsi sulle peculiarità delle persone che guidano e di trovare con ciascuno le giuste leve di ingaggio. A tal riguardo, Mercer Italia ha presentato una ricerca condotta tramite l’analisi dei dati psicometrici derivanti da oltre 5.200 questionari MAP® (Mercer Assessment of Potential), somministrati a livello globale negli ultimi 4 anni, con l’obiettivo di studiare i fattori motivazionali specifici di ciascuna generazione, per offrire una mappa che orienti le Risorse Umane nel proporre value proposition rilevanti e capaci di generare ingaggio.
L’analisi dei risultati del test proprietario MAP® (Mercer Assessment of Potential) ha rilevato differenze significative nella percezione dei diversi driver motivazionali per le persone appartenenti alle diverse generazioni, con distinzioni rilevanti dovute anche al genere.
Nel driver Mastery, relativo alla ricerca di opportunità di crescita, apprendimento e sviluppo di nuove competenze, risulta particolarmente rilevante la generazione più giovane unitamente al driver dell’Achievement, connesso alla ricerca di un lavoro per obiettivi dove potersi sfidare verso risultati importanti, delineando un quadro di bisogni per questa nuova generazione orientato all’acquisizione di competenze e alla possibilità di perseguire obiettivi concreti.
Per i Millennial è più centrale la dimensione della Recognition, il che riflette l’importanza per questa generazione di ricevere feedback e avere una buona visibilità, fattore motivazionale che tende a perdere di rilevanza al crescere dell’età e della posizione professionale. Per le generazioni più adulte, infatti, assumono rilevanza i motivatori connessi all’Impact, all’Autonomy e al Supporting Others, elemento quest’ultimo particolarmente rilevante soprattutto per i Baby Boomer, che si sentono ingaggiati nel poter mettere al servizio di altri le proprie conoscenze concrete e nel trasferire conoscenza e competenze verso i più giovani.
Queste evidenze sollecitano importanti riflessioni in merito ai modelli di leadership e all’introduzione del concetto di Leadership di Identità, che sta portando le organizzazioni a rivedere i propri modelli tradizionali, con l’obiettivo di definire uno stile di leadership capace di parlare efficacemente a individui tanto diversi ma accomunati da un elemento comune: riuscire a dare il meglio di sé nel momento in cui si viene visti e riconosciuti per le istanze specifiche di cui ciascuno è portatore.
Un esempio di sviluppo della leadership è il progetto WE LEARN che il Gruppo Generali ha avviato nel 2020. Si tratta di un innovativo programma di lungo termine che ha l’obiettivo di equipaggiare i manager con le competenze critiche di cui è necessario essere in possesso, da quelle digitali a quelle comportamentali. La formazione è stata erogata con un mix di aula e lezioni online a livello globale. Si è partiti da un’iniziativa di global skills assessment per comprendere a fondo le attuali competenze dei lavoratori e il loro livello, stabilendo successivamente delle priorità e assegnando poi specifici compiti per gruppo di utenze.
Ciò che differenzia l’approccio di Generali è proprio la strategia skill-based: l’assessment manageriale non è, dunque, avvenuto per ruolo ma per competenza, tramite una metodologia che individua le skill che risulteranno più importanti nel prossimo futuro, in linea con la strategia del gruppo e le tecnologie emergenti. Con l’aiuto di 40 Subject Matter Experts interni ed esterni, sono state sviluppate oltre 2.000 domande tecniche e situazionali in 10 lingue, basate su 26 nuove competenze. Evidentemente questo grande progetto ha richiesto il supporto di un piano di change management coerente con l’iniziativa. Hanno partecipato al programma 30 Paesi, i cui dipendenti hanno affrontato oltre 20.000 assessment completati nell’82,5% dei casi, un risultato molto positivo. Il training per competenze ha consentito un importante risparmio di costi, riducendo del 30% il tempo prima dedicato a percorsi di formazioni infruttuosi, oltre a identificare pool di competenze rilevanti che prima non era possibile rintracciare nell’ambito dell’organizzazione.
Sostenibili, sul serio
Abbiamo finora parlato dell’azienda empatica e visto come in Italia questo modello sia stato adottato dalle aziende più innovative. Oltre a questo occorre, però, che siano tutti i lavoratori a riconoscere nella propria azienda non solo un approccio di ascolto e di empatia, ma la capacità di mettere in pista tutte le funzioni aziendali per il raggiungimento nel lungo termine di un purpose comune. L’azienda relatable, emersa a gran voce dall’ultima indagine Global Talent Trends, è dunque un’organizzazione che consente ai suoi dipendenti non solo di sentirsi ascoltati, ma di scegliere ogni giorno, sia in termini individuali che di collettività, l’azienda nella quale si lavora. Se l’azienda è sostenibile, è dunque anche in grado di trasferire a tutti i suoi stakeholder un obiettivo comune che unisce e orienta verso un futuro di lungo termine che abbia un senso e un valore. Non è più tempo di promuovere iniziative occasionali volte solo a comunicare esternamente il proprio impegno etico. Se si tratta di misure vuote e poco orientate a un senso più profondo, che sia capace di fornire una risposta all’esistenza dell’organizzazione, si finirà per scontentare tutti, dagli investitori ai propri dipendenti, anche i giovani lavoratori che nel futuro potrebbero essere attratti dall’azienda e mettere a sua disposizione le proprie competenze.
L’azienda relatable assume in questo contesto un valore fondamentale, perché va ben oltre la pressione degli investitori rispetto all’implementazione di logiche ESG e abbraccia una visione etica di lungo termine nella quale tutte le sue parti si riconoscano in un’unica identità.
Per essere relatable, tuttavia, occorre avere un approccio di misurazione quantitativa e qualitativa ben strutturato, oltre che la capacità di facilitare una transizione della leadership verso modelli più attuali. Ne deriva la necessità di formazione continua della leadership e della misurazione rispetto alla messa in pratica di tali modelli. Una sfida che dura nel tempo e che genera la circolazione di valori e di obiettivi etici chiari e condivisi dall’intera azienda.
Marco Valerio Morelli, Amministratore Delegato Mercer Italia, Senior Partner.
Amelia Venegoni, Direttore Marketing Mercer Italia.
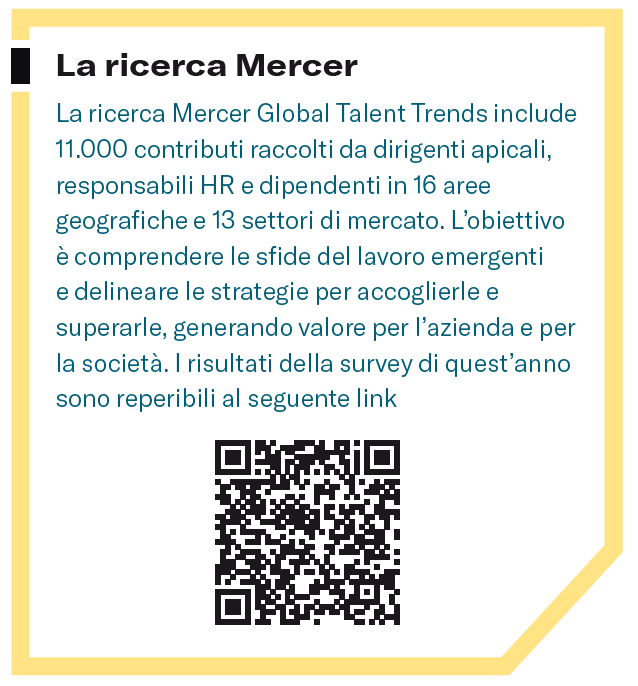
NB
Alcune fonti di questo articolo: The Wall Street Journal, “Work without Jobs”, di Ravin Jesuthasan e John Boudreau; Mercer Research, Global Talent Trends 2022; Mercer, XXIV Osservatorio sul capitale umano in Italia; Marsh McLennan Research, ESG as a Workforce Strategy; Politecnico di Milano, Osservatorio Smart Working.